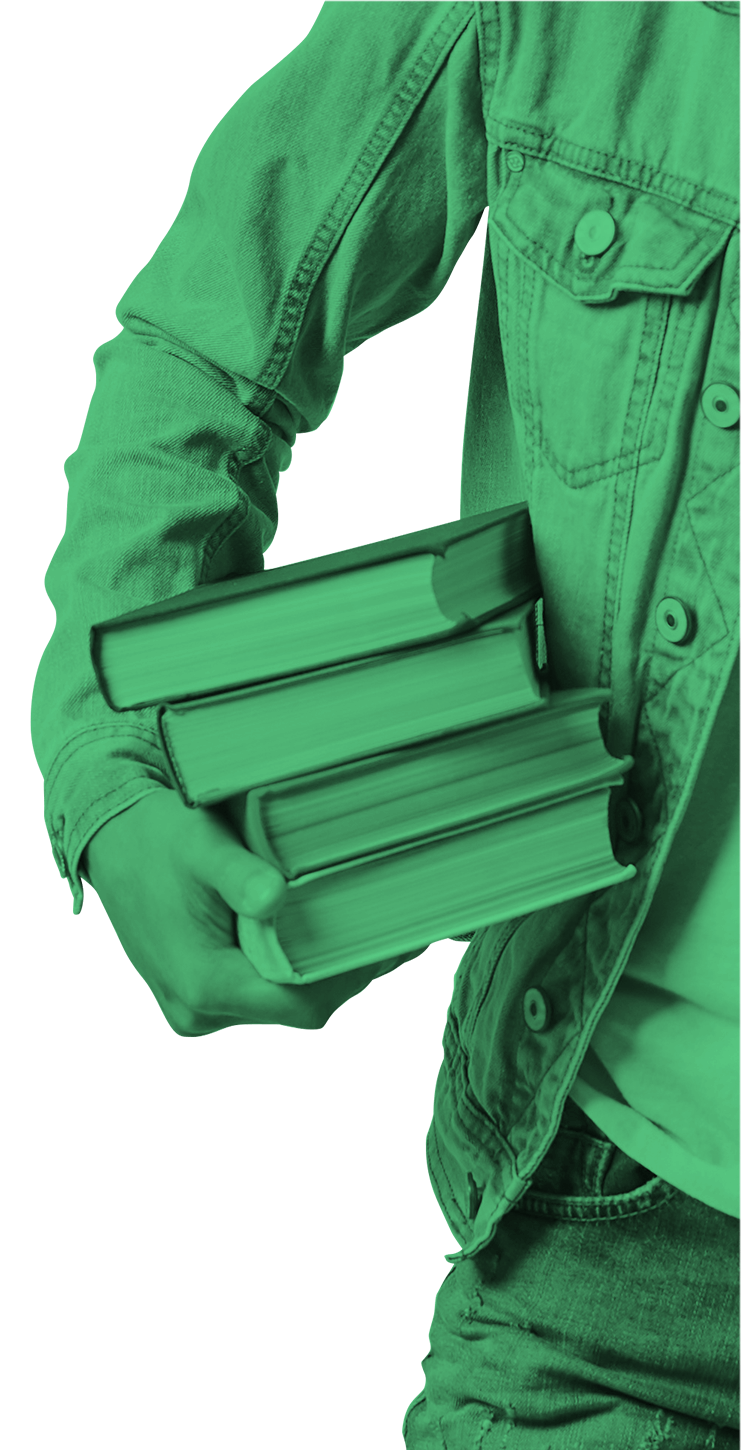Chi Siamo

Programmi
Programmi Didattici Base
Programmi Didattici Tematici
FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

Strumenti
Rubriche
 Massimo Lapucci - Manager e senior advisor, esperto di economia, finanza d’impresa e innovazione, ha una vasta esperienza in consigli di amministrazione e advisory board di società ed enti pubblici e privati di vari settori e in organizzazioni internazionali non profit, tra cui Rockefeller PA Europe, the London School of Economics-Marshall Institute, Robert Kennedy Foundation Italy.
Massimo Lapucci - Manager e senior advisor, esperto di economia, finanza d’impresa e innovazione, ha una vasta esperienza in consigli di amministrazione e advisory board di società ed enti pubblici e privati di vari settori e in organizzazioni internazionali non profit, tra cui Rockefeller PA Europe, the London School of Economics-Marshall Institute, Robert Kennedy Foundation Italy.2006 World Fellow alla Yale University e attualmente International Fellow presso il Digital Ethics Center della Yale University sui temi dell’impatto etico dell’Intelligenza Artificiale, Lapucci si occupa di data science, impact finance e filantropia.
È stato, tra l’altro, Segretario Generale di Fondazione CRT e Amministratore Delegato e Direttore Generale delle OGR Torino, hub internazionale di innovazione e accelerazione di impresa. Già Presidente di European Foundation Centre a Bruxelles, il principale ente europeo di filantropia, è docente universitario di Finanza, Corporate Governance e Sostenibilità ESG e autore di articoli e pubblicazioni tra cui è co-editor del bestseller “Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World” pubblicato da Springer.
1. In un mondo che corre velocissimo, orientato al progresso e alla produttività, è sempre più sfidante valutare la sostenibilità nella sua complessità. I classici principi ESG (Environmental, Social and Governance) che studiano l’impatto a livello ambientale, sociale e di governance hanno dei limiti? Se sì, quali?
Sì, i principi ESG, pur essendo fondamentali nell’orientare aziende e istituzioni verso la sostenibilità, hanno presentato progressivamente alcuni limiti. Uno dei principali è la tendenza a ridurre la loro applicazione a semplici metriche o adempimenti burocratici, spesso scollegati dalla realtà concreta delle comunità e delle persone. Questo approccio rischia progressivamente di svuotarli di significato, trasformandoli in strumenti di comunicazione o marketing piuttosto che in leve di cambiamento reale. Inoltre, i principi ESG si sono concentrati in molti casi quasi esclusivamente su questioni, pur rilevanti, misurabili e tangibili, finendo però per trascurare l’importanza di aspetti intangibili, come il benessere umano, la salute psico-fisica e perché no, la felicità. Questo può portare a una visione parziale della sostenibilità, che non considera adeguatamente la dimensione umana e la necessità di un equilibrio tra progresso economico, salute, e valori sociali. Infine, l’attuale struttura della sostenibilità ESG può risultare poco adatta a rispondere alle trasformazioni rapide e complesse del nostro tempo, come l’impatto dell’intelligenza artificiale o delle crisi globali.
2. Adottare il PIL come principio preponderante per la misura del grado di sviluppo di una Nazione è ancora attuale? Oppure pensa che andrebbe integrato con altri elementi?
Il PIL, pur essendo uno strumento utile per misurare la crescita economica di una nazione, non è più sufficiente da solo a rappresentare il reale grado di sviluppo, specie quando parliamo di sviluppo sostenibile. Il Pil, come configurato attualmente, ha fatto la sua storia e si limita a quantificare la produzione di beni e servizi, ma non tiene conto di aspetti fondamentali come la qualità della vita, il benessere delle persone, la sostenibilità ambientale e le disuguaglianze sociali. In un mondo che affronta sfide globali come il cambiamento climatico e la crisi della salute pubblica, è necessario poter integrare il quadro attuale con indicatori che misurino il progresso umano in modo più completo. A cominciare ad esempio, dall’Indice di Sviluppo Umano (HDI) o dal Gross National Happiness (GNH) che rappresentano strumenti utili che tengono in giusta considerazione elementi come istruzione, salute, e felicità. Solo attraverso un approccio ESG+H che combini parametri economici e sociali possiamo avere una visione più equilibrata e lungimirante dello sviluppo sostenibile.
3. Nel saggio «Ritrovare l’umano. Perché non c’è sostenibilità senza Health, Human and Happiness», scritto insieme a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, alle metriche di ESG avete affiancato anche la lettera H, utile a ragionare su altre rilevanti sfaccettature legate al tema della sostenibilità. Ci può dire qualcosa in più?
Siamo convinti che la lettera H rappresenti, specie in questo momento storico, un ampliamento necessario dei principi ESG, introducendo Health, Human e Happiness come elementi centrali per una sostenibilità più completa. La salute (intesa come global Health) è fondamentale per garantire il benessere psicofisico della Persona in ogni ambito, dall’ambiente di lavoro alla società nel suo complesso. Ma H significa anche Human, ossia la centralità dell’essere umano come Persona integrata nel ‘villaggio globale’, con diritti, dignità e necessità di equilibrio psicofisico. Happiness sottolinea la legittima aspirazione alla felicità, intesa non solo come emozione individuale, ma come benessere collettivo e armonia sociale. In questo, si inserisce perfettamente anche la quarta H di Heart che ci ricorda l’importanza dei valori come l’empatia e l’etica che devono guidare la Governance specie nei processi di decision-taking. L’idea di ESG+H è quindi un invito a superare una visione puramente quantitativa delle metriche ESG, ponendo al centro l’essere umano e il suo ruolo insostituibile per un futuro sostenibile.
4. Per un futuro in cui la Persona possa beneficiare del maggior numero possibile di strumenti per essere in armonia con il Pianeta, quanto conta l’educazione alla gestione consapevole del denaro?
L’educazione finanziaria è un elemento cruciale per promuovere un futuro sostenibile, in cui le persone possano vivere in maggiore armonia con il Pianeta, l’unico che abbiamo a disposizione. Una gestione consapevole del denaro permette di poter prendere decisioni informate, sia a livello individuale che collettivo, favorendo scelte che tengano conto non solo del profitto in quanto tale, ma anche dell’impatto sociale e ambientale generato. Ad esempio, comprendere i principi degli investimenti sostenibili (come i fondi ESG) può aiutare a indirizzare le risorse verso progetti che promuovono il benessere collettivo. Inoltre, un’educazione finanziaria diffusa contribuisce a ridurre le disuguaglianze, migliorare la resilienza economica delle famiglie - anche attraverso una maggior inclusione delle donne ancora spesso troppo escluse da una adeguata gestione finanziaria - e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di consumi responsabili. In un mondo sempre più interconnesso, insegnare alle persone a valutare l’impatto delle proprie scelte finanziarie è essenziale per costruire una società più equa e sostenibile.
5. La scadenza degli obiettivi fissati dell’Agenda 2030 si avvicina. A che punto siamo secondo Lei?
L’Agenda 2030 ha rappresentato una visione ambiziosa, una formidabile azione di education internazionale e di richiamo collettivo all’importanza di un futuro davvero sostenibile. Oggi grazie anche agli SDG dell’Agenda ONU 2030 tutti sanno cosa siano gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile. Ma a pochi anni dalla scadenza, i progressi sono disomogenei e, in molti casi, non sufficienti. Alcuni obiettivi, come la riduzione della povertà estrema, hanno registrato miglioramenti, ma altri, come la lotta al cambiamento climatico o la riduzione delle disuguaglianze, sono ancora lontani dall’essere raggiunti. La pandemia, i conflitti geopolitici e le crisi economiche globali hanno sensibilmente rallentato molti sforzi, evidenziando al contempo la necessità di un approccio più integrato e resiliente. Tuttavia, ci sono segnali positivi: la crescente consapevolezza globale sui temi della sostenibilità e il coinvolgimento di aziende, governi e società civile stanno creando un’onda di cambiamento. Anche in questo caso, non dobbiamo rischiare di buttar via quanto di buono è stato sin qui fatto - magari anche cedendo a facili lusinghe di breve termine di certa politica - ma occorre accelerare i progressi realizzati, rinnovando il nostro impegno, promuovendo soluzioni innovative e collaborazioni che mettano al centro la Persona, l’ambiente e il benessere collettivo, per un futuro decisamente più ESG+H.