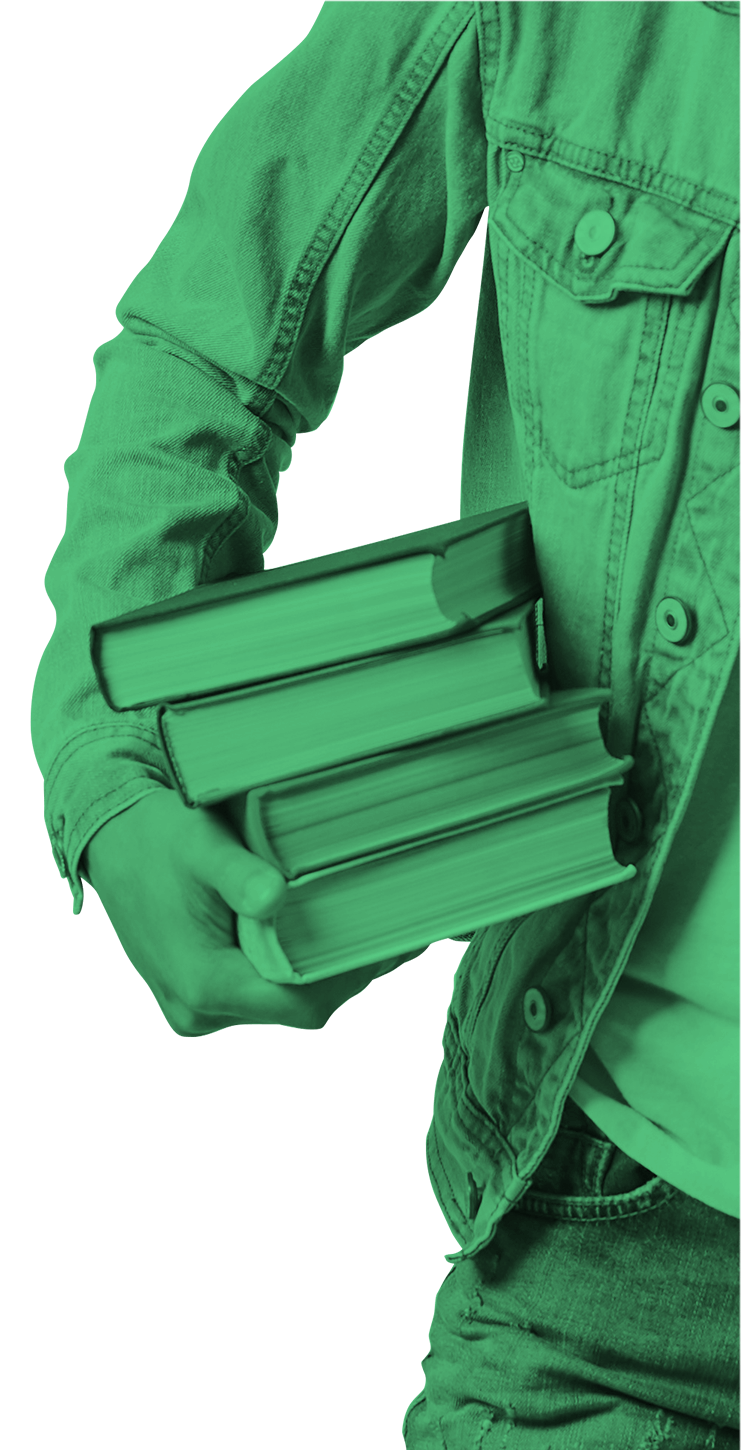Tutte le nostre attività operano per il raggiungimento dei 17 goal richiesti dall’agenda 2030 dell’ONU.

“Il Punto” è la rubrica istituzionale che ospita brevi interventi di esperti autorevoli sui temi dell’educazione finanziaria e dell’inclusione.
Leggi l’ultimo articolo!
Etica e Denaro
di Suor Alessandra Smerilli, Prof.ssa di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma
In quale misura l’educazione finanziaria e una nuova etica del denaro possono incoraggiare il cambiamento e il progresso culturale dei mercati?
Attualmente la dimensione economica nella formazione professionale e universitaria in genere è molto schiacciata sul versante aziendalista e sull’apprendimento di tecniche e di strumenti. La separazione tra cultura tecnica e cultura umanistica ha portato a non considerare l’economia come una scienza della formazione di base. Scriveva a tal proposito il filosofo italiano Giovanni Vailati nel 1899 riguardo la proposta di inserire l’economia nelle scuole superiori: «E veramente ci dovrebbe sembrare molto strano, se non vi fossimo abituati, il fatto che mentre da un giovane, che aspira ad ottenere un certificato di idoneità [un diploma], … si richiede che sappia i nove nomi delle muse o dei sette re di Roma, o in che sistema cristallizzano lo zolfo e la pirite, e non si esige invece che abbia la più vaga nozione della differenza tra imposte dirette e indirette o di ciò che sia una banca o una società anonima» (Scritti, III, p. 262). Oggi l’economia è diventata una grammatica delle relazioni umane, non solo una faccenda tecnica. Siamo immersi tutto il giorno in consumi, vendite, lavoro, prezzi, e l’educazione economico-finanziaria dovrebbe far parte della formazione del carattere dei giovani; altrimenti diventiamo sudditi economici in una società che ci vorrebbe sovrani.
Come ci ricorda Papa Benedetto nell’enciclica Caritas in Veritate al n. 35: “Il mercato, se c’è fiducia reciproca e generalizzata, è l’istituzione economica che permette l’incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri”. Ma affinché il mercato diventi questo, c’è bisogno di cittadini educati e preparati.
L’economia è faccenda etica, e nelle scelte etiche c’è bisogno di consapevolezza, quindi di conoscenza, perché, come leggiamo ancora nella Caritas in Veritate, il mercato "trae forma dalle configurazioni culturali che lo specificano e lo orientano”. Un’economia che mette al centro la persona e le sue relazioni farà del mercato un luogo di incontro, un’economia che pone al centro l’individuo e i suoi bisogni. L’abate Antonio Genovesi, riconosciuto padre fondatore dell’Economia civile sosteneva proprio questo: perché il mercato funzioni bene, c’è bisogno che si coltivino le virtù civili, la fiducia pubblica innanzitutto: Non vi è niente di più vero nelle cose umane quanto questa massima: "ogni politica, ogni economica, che non è fondata sulla giustizia, sulla virtù e sull’onore, distrugge se medesima”.
Dobbiamo ripartire dalle virtù condivise per migliorare l’economia.
La generatività è una concezione completa dell’economia e dell’uomo che pone quest’ultimo al centro, permettendogli attraverso la relazione con gli altri di raggiungere qualcosa di più prezioso del profitto, ossia il benessere sociale. Partendo da questo presupposto, possiamo concludere che l’educazione finanziaria potrebbe rappresentare un contributo a qualcosa di superiore rispetto a una semplice alternativa economica?
L’antica tradizione dell’etica delle virtù ha come suo fondamento l’idea che la virtù è, al tempo stesso, naturale all’essere umano ma è bisognosa di educazione. Siamo fatti per le virtù, ma alle virtù ci si deve educare, non sono spontanee, c’è bisogno di formare il carattere. Questo vale anche per le virtù economiche e finanziarie: il buon risparmio, il consumo sobrio e responsabile, le scelte lavorative e produttive, sono scelte etiche, che quindi richiedono educazione e formazione. Oggi il mercato, soprattutto in paesi come l’Italia, soffre anche per mancanza di una educazione e di una formazione adeguati che non può non iniziare dalla scuola.
Educazione finanziaria, infine, non deve quindi rappresentare una informazione sugli strumenti finanziari o sulle tecniche di gestione dei fondi; anche, ma soprattutto questa educazione deve partire dal senso e uso del denaro, dalle sue potenzialità e rischi, delle sue virtù e dei suoi vizi. Ottimi sono, a questo riguardo, alcuni grandi classici della letteratura, da Shakespeare (Il mercante di Venezia) a Pinocchio, che sono grandi insegnamenti etici sul denaro e sulla finanza.