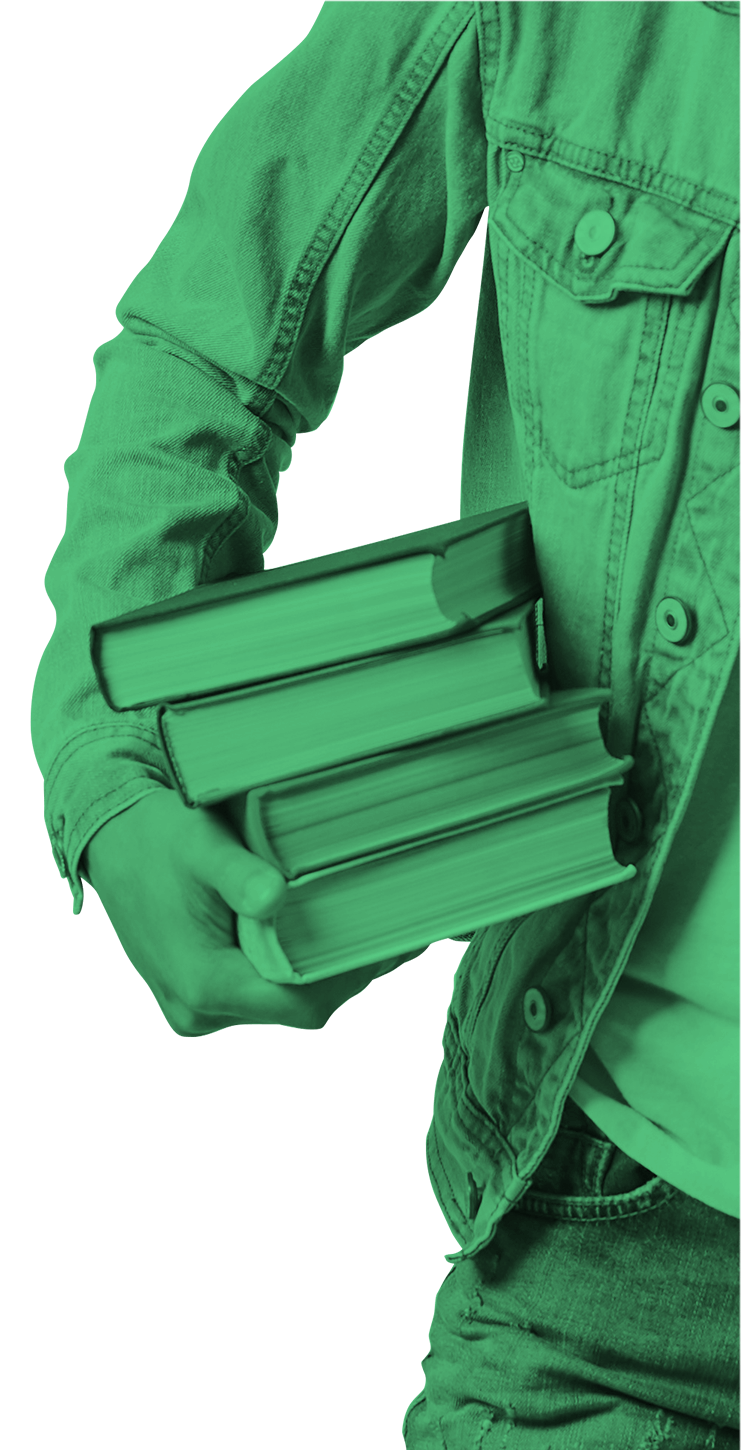Chi Siamo

Programmi
Programmi Didattici Base
Programmi Didattici Tematici
FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

Strumenti
Rubriche
 Valentina Melis è un’attrice, autrice, conduttrice televisiva e attivista impegnata nella lotta alla violenza di genere.
Valentina Melis è un’attrice, autrice, conduttrice televisiva e attivista impegnata nella lotta alla violenza di genere.Cresciuta in una famiglia operaia e politicamente attiva, ha trasformato il senso di inadeguatezza giovanile in energia e determinazione.
Fin da piccola, l’arte è stata la sua direzione naturale.
Ha studiato danza, canto, recitazione, ma accanto alla passione per la scena, ha sempre sentito forte il bisogno di sostenere le categorie marginalizzate.
È stato proprio il desiderio di approfondire le dinamiche sociali, politiche e culturali che influenzano la nostra vita quotidiana a spingerla a intraprendere anche gli studi in Scienze Politiche.
Sul fronte artistico, ha condotto programmi TV, recitato in sit‑com e film d’autore e sta portando in scena da tre anni lo spettacolo “Stai Zitta!”, tratto dal libro di Michela Murgia, di cui è autrice e protagonista.
Nel 2022 ha pubblicato il libro “Una mamma ansia e sapone” (Vallardi), una narrazione autentica e ironica della maternità.
Da quell’anno è la testimonial di Differenza Donna, associazione che da oltre 30 anni si batte per contrastare la violenza maschile sulle donne con i suoi centri antiviolenza e case rifugio.
1. Come attrice e donna, hai mai percepito barriere economiche o stereotipi di genere nel tuo percorso professionale? In che modo pensi che l’educazione finanziaria possa aiutare a superarle?
Sì, li ho percepiti eccome. Nell’ambiente dello spettacolo stereotipi di genere che generano poi barriere economiche sono ancora molto radicati, anche se spesso invisibili.
Una cosa che mi ha sempre colpita è che noi attrici, per consuetudine, non parliamo mai di soldi. Non si fa. È quasi considerato sconveniente. Lo fa l’agente, “ci pensa lui o lei”. E per molto tempo anch’io ho accettato questa dinamica, l’idea che parlare di denaro fosse qualcosa non “da artiste”. Ma oggi mi rendo conto che è anche così che si perpetua una forma di disuguaglianza. Perché se non sai quanto vali, se non sai quanto guadagni rispetto ad un collega uomo, se non conosci il mercato del tuo lavoro, non puoi davvero essere libera.
Ho imparato che anche questo è un gesto politico, parlare di soldi è un atto femminista. Questo soprattutto grazie alla stretta vicinanza con Azzurra Rinaldi, che io considero una sorella. Ci hanno educate a pensare che l’amore per l’arte dovesse bastare, che la passione compensasse tutto, anche i vuoti di tutela, anche le differenze salariali. Ma la verità è che la libertà economica è una parte fondamentale della dignità professionale.
L’educazione finanziaria, in questo senso, non è solo una questione di contabilità o investimenti ma una forma di consapevolezza. Significa conoscere i propri diritti, capire come funziona il sistema, imparare a negoziare e di conseguenza essere libere. Io penso che le donne, in qualunque campo, dovrebbero sentirsi legittimate a chiedere, a pretendere il giusto perché non c’è niente di più rivoluzionario, in una società che ancora ti vuole grata e silenziosa, che dire: “Io so quanto valgo.”
2. L’inclusione finanziaria è spesso vista come un tema tecnico. Secondo te, come possiamo renderla più “umana” e vicina alle esperienze quotidiane delle donne?
Credo che l’unico modo sia partire dalle storie. Quando parliamo di denaro o di economia, la conversazione tende subito a diventare fredda, tecnica, quasi distante dalla vita reale. Ma in realtà dietro ci sono persone, scelte, relazioni, fragilità.
Io penso spesso alle donne che incontro nei centri antiviolenza o che ho conosciuto attraverso il mio lavoro di attrice e attivista, donne che non potevano lasciare un uomo violento perché non avevano un conto corrente o perché non avevano mai gestito i soldi di casa, o perché ogni loro spesa veniva controllata. Ecco, quella non è solo mancanza di denaro, è mancanza di libertà. È un’esclusione economica che diventa esistenziale.
L’inclusione finanziaria, se vogliamo renderla davvero umana, deve parlare di questo, delle storie: della donna che non può affittare una casa da sola perché non ha una busta paga, della madre single che non riesce a ottenere un prestito perché lavora precaria, della ragazza che non sa cosa sia un contratto o una pensione perché nessuno gliel’ha mai spiegato. Per me umanizzare l’economia significa raccontare queste storie, dare loro voce e dignità. Ed è lo stesso motivo per cui amo il teatro, perché ti obbliga a guardare in faccia la realtà, senza filtri. Quando una donna racconta la sua storia di dipendenza economica, non stai più parlando di un concetto astratto ma di lei, della sua vita, dei suoi figli, del suo futuro.
E poi non deve essere vista come un lusso ma come una competenza vitale perché sapere come si gestisce un budget, come si tutela il proprio lavoro, come si risparmia o si investe cambia decisamente la nostra vita, perché impariamo a prenderci cura di noi, a proteggerci, a poterci permettere di scegliere. E le scelte, soprattutto per le donne, sono sempre un atto politico.
3. Nel tuo lavoro hai interpretato ruoli che raccontano storie di emancipazione o fragilità. C’è un personaggio che ti ha fatto riflettere sul potere dell’autonomia economica femminile?
Sì, proprio il personaggio che interpreto nello spettacolo Stai Zitta, tratto dal libro di Michela Murgia: Martina, una ballerina che decide di rinunciare alla sua carriera quando diventa madre. Martina non lo fa per costrizione, lo fa per convinzione, perché le hanno insegnato che una “buona madre” deve sacrificare tutto, anche se stessa, “all’altare della maternità”. E lei ci crede. Ci crede come ci hanno creduto in tante, ma poi arriva un momento, nello spettacolo, in cui questa convinzione comincia a sgretolarsi. Martina si accorge di non essere felice, di aver smesso di appartenersi, si rende conto che non può comprarsi nemmeno una cosa piccola senza chiedere, che dipende in tutto dal marito. Durante un monologo dice a se stessa: “Martina, ora devi chiuderti in bagno per contare le monetine che hai preso dalla tasca della giacca di Luca?” Quel momento per me è devastante, perché racconta una forma di violenza silenziosa, quella economica, che spesso non viene nemmeno riconosciuta come tale.
Eppure è terribile perché ti toglie potere, libertà, dignità e ti fa sentire piccola, sempre e comunque in debito anche quando sei tu a mandare avanti la casa, i figli, la vita. Quando porto Martina in scena sento che non sto solo raccontando una storia individuale, ma una condizione collettiva. Quante donne, ancora oggi, si trovano a fare i conti con lo stesso senso di colpa, con la stessa dipendenza travestita da amore. E allora il teatro, per me, diventa uno spazio di consapevolezza.
4. Se potessi parlare a una ragazza di 16 anni che sogna l’indipendenza, quale consiglio le daresti per costruire una consapevolezza finanziaria libera da stereotipi?
Le direi: non permettere mai a nessuno di gestire la tua libertà al posto tuo. E una parte importante della libertà passa anche dal denaro.
Da attivista e testimonial di Differenza Donna ho incontrato tantissime donne che hanno subito violenza domestica e una cosa che ritorna sempre, in tutte le loro storie, è la dipendenza economica. Donne che non potevano andarsene perché la casa era di lui, perché il conto era intestato a lui, perché “non avevano niente”.
Il problema è che per troppo tempo ci hanno insegnato che l’amore, la dedizione, la famiglia bastassero e che parlare di soldi fosse volgare, egoista, materiale, “poco femminile”. Invece è esattamente il contrario, saper gestire i propri soldi è un atto di cura, di autodifesa, di libertà.
Nei centri antiviolenza ho visto la forza incredibile delle donne che ricominciano da zero, che imparano a rifare un curriculum, ad aprire un conto, a firmare un contratto, a dire “questi soldi sono miei”. Ed è lì che inizia la rinascita, non in un gesto eroico, ma in una presa di consapevolezza quotidiana. Studia, informati, chiediti sempre quanto vali, non solo come persona, quello non ha prezzo, ma anche come professionista, come cittadina, come donna che contribuisce al mondo. E ricordarti che l’indipendenza non è un lusso, è libertà. Non c’è niente di più rivoluzionario che una donna che può permettersi di scegliere, perché una donna che può scegliere è una donna che non si lascia più comprare, né convincere, né zittire.
5. Il mondo dello spettacolo può influenzare il cambiamento culturale. Quale responsabilità senti, come artista, nel promuovere una narrazione più equa e inclusiva sul tema del denaro e del genere?
La sento e la sento tantissimo. Credo che chi lavora nello spettacolo, nel cinema, nel teatro, abbia un potere enorme: quello di modellare l’immaginario collettivo. Se per decenni abbiamo visto sullo schermo donne rappresentate come dipendenti, grate, passive o definite solo in relazione a un uomo, non è un caso che si continui a pensare a noi in quel modo. E allora sì, raccontare è una forma di responsabilità politica.
Con Stai Zitta ho capito quanto il teatro possa diventare uno spazio di presa di coscienza. Non è solo uno spettacolo, è un luogo in cui nominiamo il potere, lo sveliamo, lo smontiamo. Raccontiamo, grazie alle parole di Michela Murgia come ci abbiano insegnato a tacere, ad adattarci, a non disturbare. E il linguaggio del potere passa anche attraverso il denaro. E se non lo nominiamo, se non impariamo a usarlo, lo lasceremo sempre in mano a qualcun altro.
Io penso che fare arte sia anche un modo di disobbedire. Disobbedire a un linguaggio che ti riduce, a un racconto che ti esclude, a un sistema che ti sottopaga o ti giudica per l’età, per il corpo, per la maternità. Quando ho il privilegio di dare voce a una donna che non ne ha mai avuta, sento che non sto solo recitando, ma sto prendendo posizione. Il mondo dello spettacolo non solo può ma ha il dovere di cambiare la narrazione. Può raccontare donne libere, complesse, reali, può far capire che parlare di denaro non è un tema tecnico, ma un tema di giustizia. E io voglio continuare a fare proprio questo, usare la mia voce per spostare lo sguardo. Perché un cambiamento culturale parte sempre da lì: da una parola che finalmente rompe il silenzio.