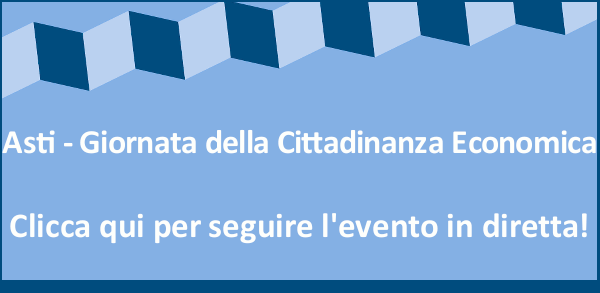Adam Smith
Seguendo l’interpretazioni più diffusa, il contributo e l’opera di Adam Smith possono essere sintetizzati affermando che l’economista e filosofo scozzese è sia il padre della scienza economica sia colui che per primo ha teorizzato in modo sistematico il funzionamento di una economia di mercato.
La vita
Adam Smith nasce a Kirkaldy, in Scozia, nel 1723 e studia filosofia prima presso l’Università di Glasgow e poi quella di Oxford. Successivamente, insegna logica e filosofia morale presso la stessa Università di Glasgow ma poi, nel 1764, abbandona l’incarico accademico per assumere quello di precettore di un rampollo della nobiltà scozzese. In veste di precettore effettua dei viaggi in Europa e soggiorna per alcuni mesi a Parigi. Nel 1767 ritorna in Scozia ed inizia la redazione de l’Indagine sulla Natura e le Cause della Ricchezza delle Nazioni, libro che sarà poi pubblicato nel 1776. Adam Smith muore ad Edimburgo nel 1790 dopo aver ricevuto l’incarico di commissario delle dogane.
Le idee
Prima di Smith le idee economiche dominanti nella Francia e nell’Inghilterra del 1600-1700 erano quelle elaborate dai cosiddetti economisti mercantilisti tra cui il francese Jean-Baptiste Colbert. Si trattava per lo più di idee funzionali alla protezione degli interessi delle grandi compagnie che dominavano il commercio internazionale tra questi paesi ed il resto del mondo. In breve, i mercantilisti identificavano la ricchezza delle nazioni – e di chi le governava – con la disponibilità di oro e di argento e da ciò nasceva la prescrizione ai sovrani di usare ogni mezzo per favorire le esportazioni ed impedire le importazioni. Le esportazioni, infatti, garantivano l’afflusso di metalli preziosi mentre le importazioni, al contrario, ne causavano il deflusso. Queste idee apparivano all’epoca sensate, favorivano i potenti e, soprattutto, solleticavano le ambizioni dei regnanti che nella disponibilità di tanto oro intravvedevano la possibilità di allestire eserciti da usare poi in guerre di conquista. Il governo dell’economia, pertanto, si materializzò nell’emanazione di leggi e regolamenti – e nella nascita di apparati burocratici deputati alla loro applicazione – aventi lo scopo di favorire le esportazioni e di impedire le importazioni. I dazi alle importazioni costituivano l’asse portante di questo tipo di intervento.
In contrasto con i mercantilisti dell’epoca, Adam Smith individua l’origine della ricchezza delle nazioni non nella disponibilità di metalli preziosi ma nella produzione agricola e manifatturiera. Un paese non è ricco perché dispone di tanto oro ma è ricco perché produce grano e manufatti. Sono le quantità di merci prodotte e disponibili per il consumo – oggi diremmo il prodotto interno lordo – la vera causa e la vera misura del benessere economico. Ne segue che una nazione può accrescere la sua ricchezza solo se produce quantitativi maggiori di beni ovvero solo se le sue attività produttive diventano più efficienti.
Ma quali sono i fattori che stimolano l’efficienza produttiva? La risposta di Smith a questa domanda è precisa ed acuta. Oltre all’impiego di mezzi di produzione che consentono di risparmiare lavoro, per Smith il fattore che più di tutti rende la produzione efficiente è la specializzazione produttiva.
La specializzazione produttiva genera efficienza a livelli diversi, al livello dei singoli individui così come al livello delle imprese e di intere nazioni. Per quanto riguarda gli individui, Smith osserva che se le persone si specializzano nel produrre il bene per il quale ciascuno ha maggiore talento, piuttosto che produrre tutti i beni di cui ciascuno ha bisogno, la produzione complessiva di una regione oppure di una città non può che aumentare. Per quanto riguarda le imprese, invece, Smith osserva che se i lavoratori vengono impiegati in modo tale che ciascuno si occupa solo di una piccola fase del processo produttivo, allora la produzione complessiva è di gran lunga superiore a quella che si realizzerebbe se ciascuno fosse impiegato in tutte le fasi. E’ inevitabile che, ripetendo nel tempo una stessa operazione, il lavoratore impari a svolgerla in modo veloce ed efficiente. Si tratta del cosiddetto learning by doing molto caro agli economisti moderni. Infine, ragionando al livello di intere nazioni, Smith osserva come sia uno spreco di risorse ostinarsi a produrre uva in Scozia dato che la stessa coltura richiederebbe meno sforzi e meno risorse in Francia. E’ più efficiente dunque che la Francia si specializzi nella produzione di derrate alimentari e la Scozia in quella di manufatti. Se le nazioni si specializzano allora il mondo intero, nella sua globalità, potrà disporre di una quantità maggiore sia di derrate alimentari che di manufatti.
Ma la specializzazione ha un ovvio presupposto. Chiunque si specializza nella produzione di un certo bene deve poi poterlo scambiare con tutti gli altri beni di cui ha bisogno. Insomma, la specializzazione ha bisogno del mercato e quanto più vasti e ben funzionanti sono i mercati concreti tanto più spinta ed efficace può essere la specializzazione.
Ma per Smith il mercato non è semplicemente il luogo in cui si scambiano le merci, è anche il luogo in cui gli imprenditori traggono indicazioni su cosa produrre oppure cosa cessare di produrre. Se i consumatori desiderano fortemente un certo bene, il suo prezzo salirà e gli imprenditori, avidi di profitti, investiranno più risorse nella produzione di questo bene. Per converso, se i consumatori smettono di desiderare un certo bene, i prezzi scenderanno e gli imprenditori, onde evitare perdite, dismetteranno i loro investimenti nella produzione. Insomma, il meccanismo dei prezzi di mercato offre indicazioni su come impiegare le scarse risorse a disposizione nell’economia. E si tratta di un meccanismo efficiente dato che le risorse vengono continuamente reindirizzate verso quei settori e quei beni che sono desiderati dai consumatori e che, quindi, producono una maggiore utilità.
L’impiego delle risorse nella produzione dei beni che sono più richiesti ed il disimpiego dalla produzione dei beni non richiesti non è guidata dall’alto ma è l’effetto spontaneo di tante piccole decisioni imprenditoriali adottate in autonomia da singoli individui. Ciascuna di queste piccole decisioni, inoltre, non ha per obiettivo il benessere della collettività ma il puro ed egoistico tornaconto privato. Un imprenditore investe nella produzione di un bene molto richiesto perché desidera realizzare un buon profitto e non perché sia motivato dal desiderio di soddisfare un bisogno espresso da altre persone. Eppure, quello che accade nella realtà è che alla fine questi bisogni vengono effettivamente soddisfatti!
E’ la mano invisibile del mercato, dunque, il meccanismo che riesce ad armonizzare interesse privato e benessere sociale. Ciascun individuo persegue il proprio fine ed assume decisioni che non sono coordinate con quelle degli altri individui. Tuttavia, il perseguimento del proprio tornaconto e l’assenza di coordinamento non generano caos ma ordine economico, non causano lo spreco di risorse ma il loro impiego efficiente. Il sistema capitalistico fondato sullo scambio di mercato si rivela un buon sistema per la società e, allo stesso tempo, appare conforme all’egoismo economico tipico della natura umana.
Ma se la mano invisibile del mercato genera ordine ed efficienza allora l’indicazione che bisogna trarre è che questa mano invisibile debba essere lasciata libera di operare. Le prescrizioni di politica economica di Smith, pertanto, si collocano agli antipodi rispetto a quelle dei mercantilisti e rappresentano storicamente la prima enunciazione del cosiddetto liberismo economico fondato su presupposti teorici. L’interventismo dello stato, l’eccessiva regolamentazione dei commerci, i dazi alle importazioni, gli apparati burocratici di controllo vengono considerati da Smith come degli ostacoli per il corretto funzionamento dei mercati ed, in definitiva, per la prosperità economica di una nazione.
Lo Stato per Smith deve contenere la sua presenza nell’economia e deve limitarsi a fornire quelle infrastrutture e quei servizi che consentono ai mercati di funzionare bene. In particolare, lo Stato deve occuparsi dell’ordine pubblico e dell’amministrazione della giustizia, della difesa del paese e, infine, della costruzione di opere di pubblica utilità. Senza una giustizia che funziona, ad esempio, chi non rispetta un contratto non verrà punito a dovere e la certezza di impunita genererà un clima di sfiducia e di diffidenza che sono di ostacolo per l’efficiente funzionamento dei mercati.
In aggiunta a queste funzioni essenziali dello Stato, Smith giustifica una sola forma di intervento della mano pubblica nel governo degli affari. Si tratta degli interventi destinati a prevenire quei comportamenti che gli economisti moderni chiamerebbero anticompetitivi. Smith è infatti consapevole che esiste una naturale tendenza da parte degli imprenditori ad accordarsi e colludere ai danni dei consumatori. Questo potrebbe accadere, ad esempio, se gli imprenditori formano una associazione e predispongono dei tariffari che di fatto impediscono la concorrenza sul prezzo.
Adam Smith è oggi considerato non solo il padre della scienza economica ma anche il punto di riferimento più nobile per coloro che ritengono che il libero mercato rappresenti la forma più efficiente di organizzazione dell’economia. I due secoli che ci separano da Smith, tuttavia, hanno consentito alla scienza economica di progredire nello studio sul funzionamento dei mercati e di mettere a fuoco una serie di problemi che Smith non aveva compreso. In primo luogo, è vero che il libero mercato produce degli esiti produttivi efficienti ma, come dicono gli economisti, non è detto che gli esiti distributivi siano altrettanto desiderabili. Lasciati a se stessi, infatti, i mercati possono generare enormi disparità nei redditi e nel benessere di coloro che vi partecipano. In secondo luogo, quando si distaccano dalla cosiddetta concorrenza perfetta, non è più vero che i mercati sono efficienti. Già Smith aveva notato l’intrinseca tendenza a formare cartelli. Ma i cartelli e, più in generale, i comportamenti anticompetitivi sono solo una tra le tante ragioni per cui i mercati reali si distaccano dall’ideale della concorrenza perfetta.
In definitiva, gli economisti moderni sono tutti convinti che lo Stato debba intervenire per regolare il funzionamento dei mercati e dell’economia, ciò che li distingue è solo una diversità di opinioni su quanto debba essere incisivo questo intervento.